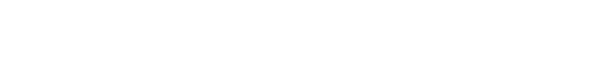Il mercato pubblicitario sta cambiando e sempre più comuni sono diventate le pubblicità indirette o, peggio, occulte in internet e sui social network più popolari.
La pubblicità indiretta è un tipo di pubblicità che compare in maniera chiara ed esplicita in spazi non tipicamente pubblicitari, senza però essere segnalata come tale. È invece pubblicità occulta la pubblicità che avviene in modo non palese. Questa pratica è vietata dalla legge italiana ma limitatamente alla televisione. E, sebbene film e telefilm siano un terreno fertile per il proliferare di questo tipo di sponsorizzazione, nuove sfide si sono aperte soprattutto sui social network. Infatti, dato che questi spazi rappresentano una nuova opportunità di manifestazione del proprio pensiero e dei propri interessi e gusti e un nuovo mezzo per apprendere e condividere informazioni e contenuti, anche le aziende hanno cominciato ad utilizzarli, in maniera esplicita o poco manifesta.
Da una parte troviamo veri e propri spot pubblicitari, come le sponsorizzazioni dichiarate, anche se non del tutto controllate: Facebook e Instagram, ad esempio, verificano che le inserzioni non contengano contenuti illeciti o proibiti dal regolamento interno, ma non controllano la veridicità delle informazioni comunicate, né la loro congruità a delle norme, visto che non esiste alcun codice di disciplina da rispettare.
Dall’altra c’è l’advertising che non si dichiara ma si fa, il cosiddetto product placement all’interno dei profili più cliccati.
A questo proposito, lo scorso gennaio la Competition and Markets Authority, agenzia governativa inglese che tutela la concorrenza sui mercati, si è pronunciata contro la pubblicità occulta, ovvero quella forma di pubblicità che non è indistinguibile da contenuti comuni nelle foto o nei video pubblicati. Chi si era spinta molto oltre era stata, tempo prima, la Federal Trade Commission americana che, per la prima volta, ha affrontato la questione, chiedendo alle celebrità della moda, dello sport e in generale agli influencer di rendere riconoscibili le loro redditizie collaborazioni commerciali attraverso hashtag o commenti.
Una normativa di riferimento però non c’è ancora e nemmeno le condizioni di utilizzo di siti come Instagram prevedono qualche tipo di regola. Ci si domanda quindi se si tratti di attività conformi alle norme del nostro ordinamento, in relazione soprattutto alla tutela il consumatore che, oltre a non dover essere soggetto a spot non veritieri e ingannevoli, ha diritto di poter distinguere i contenuti a scopo pubblicitario da quelli di puramente “di tenedenza”.
Recentemente, l’Unione Nazionale Consumatori ha interrogato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per chiedere che si verificasse la legittimità dell’attività pubblicitaria occulta sui social network. La base giuridica di tale contestazione è l’articolo. 22 del Codice del Consumo secondo il quale l’intento commerciale dev’essere esplicitamente indicato qualora non sia reso evidente dal contesto o, comunque, se è idoneo a indurre in errore il consumatore.
L’AGCM dovrebbe dunque fare chiarezza e fornire informazioni adeguate sia sul rapporto interno tra produttore e influencer, sia sulla necessità di indicare in maniera esplicita e senza alcuna possibilità di fraintendimento il fine pubblicitario dell’attività.
Nel frattempo, Instagram ha lanciato un nuovo tag, “Paid Partnership with”, in modo che gli utenti possano inserirlo sia nelle storie che nei post pubblicati per denunciare la presenza di una pubblciità. In alternativa, molte blogger, tra cui la più celebre è Chiara Ferragni, hanno iniziato ad utilizzare alcuni “claim-hashtag”, come #ad, #advertisement o #pubblicità, per evidenziare lo scopo commerciale della loro foto, in modo da contribuire, seppur in modo non sufficiente, ad una tutela del consumatore.